
Ciao Danilo, sei pronto per questo piccolo viaggio insieme?
Decisamente :)
Iniziamo, come hai deciso di fare questo lavoro e perché?
Non ho scelto io il mio lavoro, ma lui a scegliere me.
La lettura ha sempre fatto parte della mia vita, sin da piccolissimo. Era estate. Siamo nei primissimi anni ‘90. Ricordo ancora vividamente quando il libro “Nella foresta” di Tiziano Sclavi, illustrato da Carlo A. Michelini ed edito da La Coccinella, riposto insieme ad altri libri sul bancone di una bancarella ambulante, catturò la mia attenzione al punto che i miei genitori furono costretti ad assecondare il mio desiderio di averlo e sfogliarlo. Si tratta di un libro cartonato sagomato per giocare alla scoperta del mondo che popola la foresta! Già dalla copertina è possibile scorgere alcuni animali nascosti tra piante della foresta, ti lascio immaginare la curiosità.
Quel giorno, la magia si presentò.
Oggi sono il responsabile della Biblioteca comunale Adriana Marsella, il coordinatore del Patto locale per la lettura di Cisterna e il coordinatore del progetto locale Nati per Leggere Nord Pontino (Cisterna, Cori ed Aprilia). Sostanzialmente, mi occupo della promozione del libro e della lettura.
Perché la lettura? Perché è una fonte illimitata di benessere.
Migliora le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del testo. Aumenta la conoscenza del mondo ma anche la conoscenza di sé e degli altri, mantiene attive le funzioni cognitive di memoria, attenzione e concentrazione, ragionamento e capacità critica.
I libri insegnano a comprendere il mondo, ad approfondire, a riflettere, a pensare. Propongono la calma e la temperanza.
Le storie permettono di accedere alla sfera dei sentimenti e delle emozioni dei protagonisti e in questo modo aumentano l’alfabetizzazione emotiva. Il vocabolario emotivo diventa più ampio e ciò migliora la definizione, l’espressione e la comprensione delle emozioni proprie e altrui. L’immedesimazione nei personaggi delle storie consente di sviluppare la capacità di sentire l’emotività dell’altro, l’empatia.
Cosa vuol dire per te la lettura ed in particolare, perché dedicarsi proprio alla letteratura d’infanzia?
“Non esistono forse giorni della nostra infanzia che abbiamo vissuti tanto pienamente come quelli che abbiam creduto di aver trascorsi senza vivere, in compagnia d’un libro prediletto… ancor oggi, se ci capita di sfogliare quei libri di un tempo, li guardiamo come se fossero i soli calendari da noi conservati dei giorni che furono, e con la speranza di veder riflesse nelle loro pagine le dimore e gli stagni che più non esistono”.
Un pensiero, quello cristallizzato nelle parole di Marcel Proust, che rappresenta totalmente l’importanza della lettura fin dall’infanzia che, tra storie ed immaginazione, diventa per un bambino un incredibile strumento per la comprensione del mondo e di sé stesso.
Cosa speri di lasciare/insegnare?
Spero di lasciare una biblioteca che possa definirsi “la casa dei cittadini”, un luogo messo a disposizione per l’intera comunità per: incontri, eventi, festival, rappresentazioni, mostre d’arte, sala giochi, concepita come uno spazio per le persone, che permetta loro di leggere, studiare, giocare, rilassarsi, dialogare ed incontrarsi; custodire e veicolare luoghi, suoni, memorie e tradizioni; essere un porto aperto alle culture.
Cosa hai imparato da questo lavoro?
Il pregio maggiore è avere la possibilità di arricchirsi e di estendere le proprie conoscenze ad ogni contatto con gli utenti e ad ogni richiesta di aiuto nelle ricerche. Inoltre, il contatto continuo con i libri proietta il proprio mondo in mille altri mondi.
Ma la cosa che più ho imparato è l'utilità del servizio, ovvero la capacità del servizio stesso di rispondere ai bisogni dell'utenza. Bisogni che sono, sì, i bisogni espressi, ma anche i bisogni inespressi e latenti. Questi ultimi sono quelli non sentiti, non attivati perché l'ambiente non dà, non offre gli stimoli necessari ad attivarli: se la biblioteca resta appiattita su una situazione consolidata di attività e non segue, per es., l'evoluzione dei tempi e del contesto, se non è anche propositiva, ben difficilmente saprà rispondere ai bisogni latenti della collettività. I bisogni inespressi sono quelli sentiti come tali, ma per il loro soddisfacimento non ci si rivolge alla biblioteca perché si ritiene che questa non sia in grado di offrire la risposta. Un es. per chiarire: devo riparare un elettrodomestico o cucinare un piatto particolare? Non mi viene in mente di passare in biblioteca per cercare un manuale di fai da te; non ho in mente questa come possibile soluzione al mio problema. I bisogni espressi sono infine quelli che la collettività esprime esplicitamente, ricorrendo alla biblioteca per il loro soddisfacimento. Ne consegue che i bisogni della collettività hanno a che fare direttamente con le aspettative che la biblioteca riesce a generare, e quindi con il ruolo che biblioteca stessa assume all’interno della comunità.
Obiettivi futuri? Sogni?
Studiare, studiare e studiare. Sogno di non smettere mai di imparare, di meravigliarmi e di amare.
Come vedi il mondo della lettura tra 10 anni? E cos’è cambiato da 10 anni a questa parte?
La lettura è una creazione dell’uomo in quanto essere dotato di intelligenza e di pensiero. Non è, dunque, un elemento che caratterizza la vita umana fin dal principio, ma, come afferma Andrew Piper: “la lettura è parte integrante della nostra esperienza vissuta, del nostro senso dell’essere nel mondo”.
Secondo la tesi della neuroscienziata cognitiva Maryanne Wolf, sostenuta nel suo saggio “Proust e il calamaro: Storia e scienza del cervello che legge” (Vita e Pensiero, 2012), noi “non siamo nati per leggere”. Dunque, la lettura non sarebbe un’attitudine naturale dell’uomo e la scrittura rappresenterebbe solo un suo frutto, una sua geniale invenzione.
La nascita della scrittura risale a circa 6000 anni fa quando, in Mesopotamia, si diffusero le prime tavolette di segni cuneiformi. Da allora la scrittura ha assunto molteplici forme fino a configurarsi nel modo in cui la conosciamo noi adesso. Dalle tavolette d’argilla ai rotoli, passando per i papiri e le pergamene, si giunge ai primi manoscritti e, infine, nel 1455, alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Quest’ultimo fu l’evento cruciale per la nascita delle moderne forme di scrittura. Ma la rivoluzione non si ferma con i libri stampati e oggi siamo giunti fino ai testi virtuali e alla lettura digitale. Con il suo lavoro, la Wolf ci indica l’immensa portata di elaborazione culturale che la scrittura ha introdotto nella vita di ogni essere umano e che non si ferma mai, ma va sempre ricercando nuove forme e nuovi modi di manifestarsi.
La scrittura è alla base del libro, in qualunque forma esso si manifesti, che rappresenta il maggior veicolo di diffusione del sapere. Le forme di scrittura si sono trasformate nei secoli così da potersi adattare alle nuove esigenze sociali; in questo scenario, senza dubbio, la rivoluzione più eclatante è rappresentata dall’introduzione del digitale.
La rivoluzione tecnologica ha segnato una profonda spaccatura tra il passato e il futuro del libro.
Personalmente, ritengo che non è che cambierà la lettura, ma il medium attraverso cui i libri si manifestano; inoltre, noi non leggiamo meno, semplicemente leggiamo in un altro modo.
Grazie
Grazie a te per il tempo e lo spazio.
[Francesca Lopez]
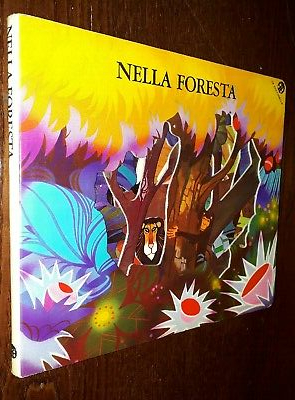
“Nella foresta” di Tiziano Sclavi, illustrato da Carlo A. Michelini edito da La Coccinella, 1985
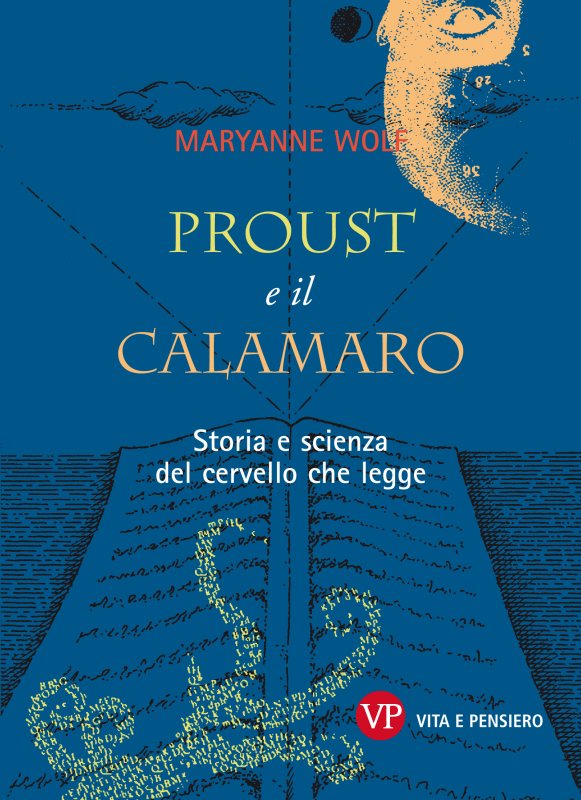
“Proust e il calamaro: Storia e scienza del cervello che legge” di Maryanne Wolf edito da Vita e Pensiero, 2012
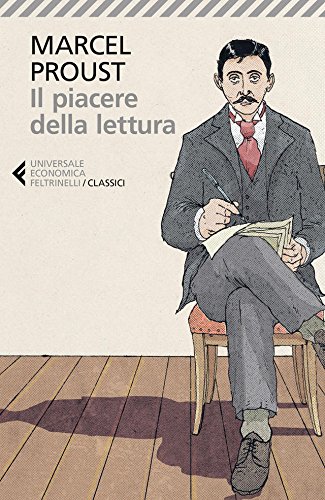
“Il piacere della lettura” di Marcel Proust edito da Feltrinelli, 2016
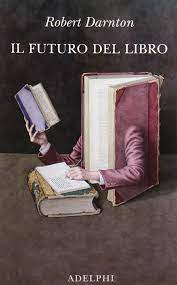
“Il futuro del libro” di Robert Darnton edito da Adelphi, 2011
Articoli Recenti
Notiziario
Iscriviti per ricevere la nostra newsletter.


